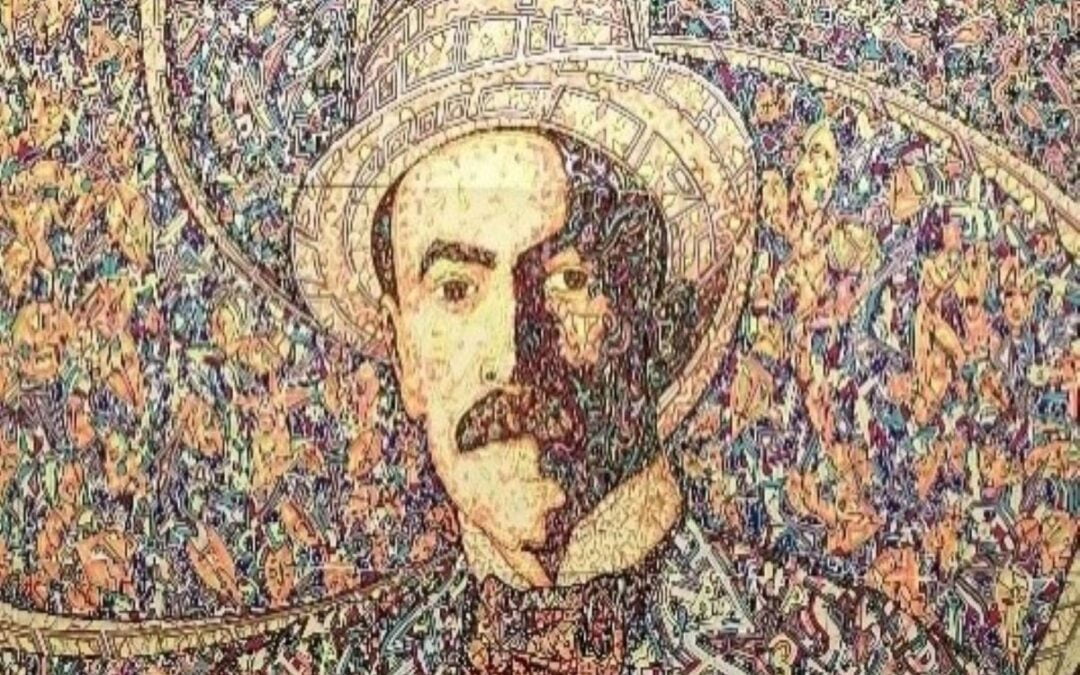Orlando Furioso: l’incompiutezza della querelle nel mondo
Orlando Furioso: l’incompiutezza della querelle nel mondo
Quello dell’Orlando Furioso è un mondo fatto di apparenze, prime tra tutte le convenzioni sociali. L’apparenza acquisisce le sembianze di sostanza e l’insensatezza dell’agire umano è spacciata per senno: tutti si credono assennati e invece hanno smarrito la ragione, primo tra tutti il paladino Orlando.
Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese io canto. Basta pronunciarne i primi versi per riconoscere l’incipit di uno dei poemi più celebrati della storia della letteratura italiana: l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, poema cavalleresco pubblicato in edizione definitiva nel 1532.
La follia di Orlando è tra le più celebri dell’epica, impazzito per l’amore della bella Angelica, il cavaliere carolingio smarrisce il senno, diserta ogni dovere militare e priva del suo necessario intervento l’esercito di Carlo Magno intento a intraprendere una guerra contro i temuti Saraceni.
Sulla vicenda del paladino cristiano si innestano e intrecciano le trame degli altri personaggi, in un gioco di incontri, scontri e smarrimenti tra le radure di una selva intricata.
È proprio nella selva che la follia di Orlando raggiunge il suo culmine quando si imbatte in un’incisione sulla corteccia di un albero che suggella la promessa d’amore tra la giovane Angelica e il saraceno Medoro. La scoperta è vissuta dal protagonista come tradimento, portandolo a smarrire totalmente la ragione. Distrugge tutto ciò che ha intorno, si spoglia dell’armatura e nudo, folle, giace a terra digiuno per tre giorni per poi prendere a vagare nella selva in preda alla follia.
Orlando è chiamato furioso, ed è infatti un furor d’amore e di gelosia che lo infiamma e lo porta a percorrere un cammino inverso a quello di elevazione dell’uomo attraverso il nobile sentimento amoroso. L’amore non eleva Orlando, non sublima, ma lo abbassa a una condizione ferina, bestiale, lo priva dell’onore e di sé.
È proprio a seguito della follia del protagonista che si innesca una querelle necessaria allo scioglimento della vicenda: il viaggio del paladino cristiano Astolfo sulla luna. È un viaggio che ha dell’onirico e del surreale, nel quale si intessono rimandi letterari, dove il lettore rimane suggestionato per il rapporto dialettico peculiare che si instaura tra il mondo lunare e quello terrestre.
In un vallone lunare, si trovano accumulate tutte le cose che sulla terra sono andate perdute. La luna è un mondo complementare alla terra e sulla luna Astolfo ha modo di trovare anche il senno di Orlando. Esso è custodito in un’ampolla e lo spettacolo che si mostra è paradossale: tutti sulla terra sono convinti di possedere il senno, eppure sulla luna ce n’è una grandissima quantità. Non solo, ma esso è anche inconsistente, un vapore labile e fugace, la cui immaterialità esprime tutta la facilità con cui è possibile smarrirlo e la difficoltà che è richiesta per recuperarlo.
La Luna con i suoi oggetti perduti funge da catalogo dei fallimenti umani esprimendo quel rapporto frustrato tra desiderio ed effettivo raggiungimento di cui Orlando è il massimo esempio. Egli desidera ardentemente Angelica, ma non la può possedere e il desiderio di lei si accresce quanto più lei si allontana fino a concedersi a Medoro. È il desiderio destinato a restare insoddisfatto che prende forma nel contrasto realtà-apparenza.
L’episodio di Astolfo sulla luna è particolarmente interessante perché si innesta su una tradizione di “viaggi nell’aldilà” che vede precedenti letterari di rilievo, in particolare il Somnium Scipionis descritto da Cicerone e il Paradiso Dantesco. È il motivo del viaggio condotto in un mondo parallelo a quello terrestre, che disvela verità nascoste e porta all’acquisizione di nuove consapevolezze.
La luna non è soltanto un luogo fisico, ma è il punto di arrivo di un’astrazione intellettualistica, di una inchiesta volta al recupero di qualcosa di effimero ed evanescente come il senno del giovane Orlando e di tutti gli uomini con lui. Si tratta del motivo della vanitas, l’insensatezza delle azioni umane indirizzate a obiettivi vani e irraggiungibili. Quasi un’auspicio che l’umanità stessa tornata sulla terra possa recuperare il senno e con esso un modo di agire nel mondo più autentico.
Astolfo farà ritorno sulla terra e grazie al suo intervento Orlando potrà recuperare il senno portando al naso i vapori dell’ampolla che gli consentiranno di tornare in sé e condurre a termine il suo compito di paladino nello sconfiggere il nemico. Questo lo costringerà però al contempo a rinunciare all’amata Angelica. L’opera suggella in questa come in altre fallite inchieste (per esempio quella di Ruggiero e Atlante) come ci sia una distanza invalicabile tra l’oggetto del desiderio e il soggetto che lo desidera, essa si traduce in un elenco di vanitas vanitatum.
Il fallimento rivela l’inconsistenza dell’agire umano, porta il lettore a una riflessione che al contempo è l’espressione di un sentimento di delusione di fronte a un mondo di corte, quello della corte ferrarese del Cinquecento, nei confronti del quale Ludovico Ariosto si interroga. La corte è il luogo delle apparenze e delle relazioni effimere, rispetto alle quali l’autore rivendica un desiderio di autenticità che sembra calarsi nell’oggi più attuale che mai.

Martina Tamengo
U. Eco una volta disse che leggere, è come aver vissuto cinquemila anni, un’immortalità all’indietro di tutti i personaggi nei quali ci si è imbattuti.
Scrivere per me è restituzione, condivisione di sè e riflessione sulla realtà. Io mi chiamo Martina e sono una studentessa di Lettere Moderne.
Leggo animata dal desiderio di poter riconoscere una parte di me, in tempi e luoghi che mi sono distanti. Scrivo mossa dalla fiducia nella possibilità di condividere temi, che servano da spunto di riflessione poiché trovo nella capacità di pensiero dell’uomo, un dono inestimabile che non varrebbe la pena sprecare.