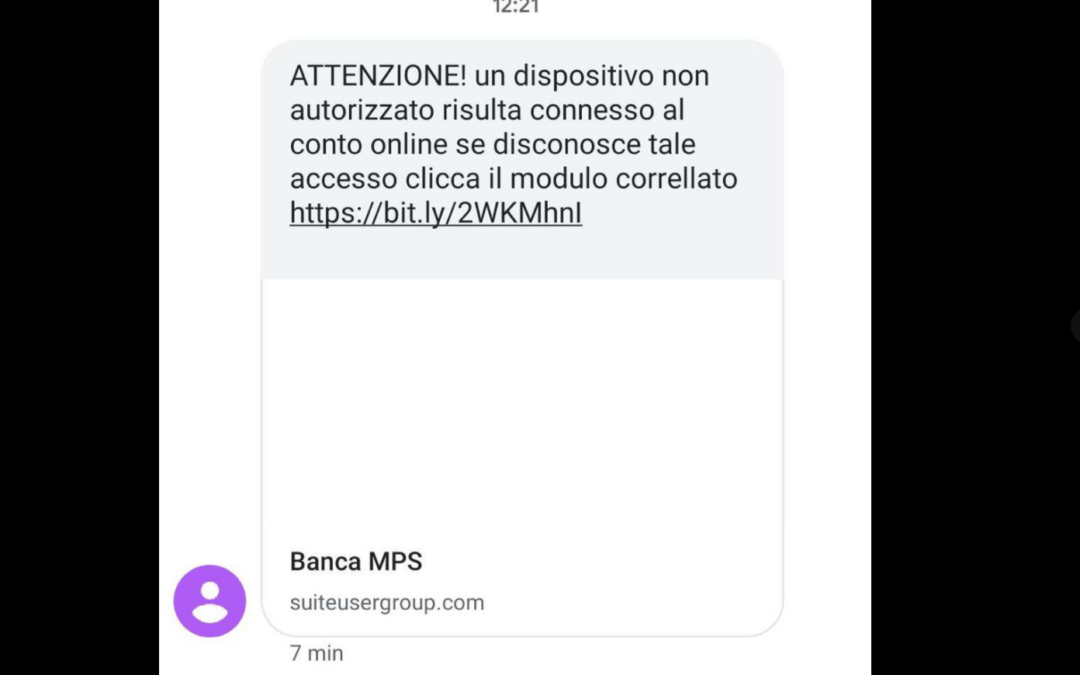Jana Karšaiová, Divorzio di velluto (Feltrinelli)
“Come si sopravvive allo strappo, alla perdita delle radici? Cosa resta, come ci si inventa di nuovo? Katarína torna da Praga a Bratislava per trascorrere il Natale insieme alla famiglia. Alle vecchie incomprensioni con la madre, si aggiunge la difficoltà di giustificare l’assenza del marito Eugen. Ma in quei pochi giorni ritrova anche le vecchie compagne di università, soprattutto Viera, che si è trasferita in Italia grazie a una borsa di studio e torna sempre più malvolentieri in Slovacchia. Le due amiche si riavvicinano, si raccontano l’un l’altra gli strappi, le ferite – Viera con Barbara, che era stata la loro insegnante di italiano, Katarína con Eugen, che l’ha abbandonata due mesi prima con un biglietto sul tavolo della cucina. Katarína ripercorre il rapporto con lui, dal primo incontro al matrimonio forse troppo precoce, con le tante difficoltà di integrarsi a Praga, fino al dolore, di cui ancora non riesce a parlare. E tra i ricordi emergono frammenti della vita a Bratislava sotto il governo comunista: l’abolizione delle festività cattoliche, la censura, le code per la carne e per qualsiasi cosa. Con “divorzio di velluto” si intende la separazione tra Slovacchia e Repubblica Ceca, che nel romanzo riverbera quelle tra Katarína e il marito Eugen, tra Viera e un paese per lei troppo stretto… È una storia di assenze che pesano, di tradimenti, di desideri temuti e mai pronunciati, di strappi che chiedono nuove risorse per essere ricomposti, di sradicamento e di rinascita – una ricerca di sé della protagonista e del suo paese, entrambi orfani di un passato solido. La scrittura versatile e profonda di Jana Karšaiová è straordinaria per un’autrice che ha scelto l’italiano come lingua elettiva. Un esordio letterario di grande maturità.”
Marino Magliani, Il cannocchiale del tenente Dumon (L’Orma)
“Estate 1800. Tre soldati napoleonici stanchi della guerra. Alle loro spalle la campagna d’Egitto e i suoi inferni, leniti appena dalla scoperta di una nuova, dolce droga: l’hascisc. Travolti dalla baraonda di Marengo – «la battaglia che alle cinque era persa e alle sette era vinta» –, disertano e si danno alla macchia. Sulle tracce dei tre si mettono gli emissari del dottor Zomer, un medico olandese che ha orchestrato un singolare «esperimento sanitario» per indagare gli effetti della nuova sostanza. Smarriti in un paesaggio ligure che pullula di spie e uniformi ormai tutte indistintamente nemiche, Lemoine, Dumont e Urruti – un capitano erudito, un tenente sognatore e un rude soldato basco – incontrano sulla propria strada amori difficili, illusioni perdute e la gioia del sole. Scopriranno così la libertà di scrollarsi di dosso la Storia per inseguire una vita fatta di attimi e di scelte. Forte di una prosa di precisa bellezza, Marino Magliani dirige una narrazione mossa e visionaria, alternando la velocità della grande avventura all’ampio respiro della pittura di paesaggio.”
Davide Orecchio, Storia aperta (Bompiani)
“«Chi siamo noi?», ci chiediamo all’inizio di questo romanzo. «Noi siamo ignoranti. Noi siamo, in miliardi di pixel, gli eredi», coloro che vivono ormai fuori della linearità storica, dove il solo modo per capire i nostri padri è studiare. Così, in principio c’è un padre bambino, appena nato e già pronto ad affrontare il Novecento perché è un «bambino diacronico», «creatura della durata». Grazie alle parole che ha scritto – perché i bambini diacronici hanno lasciato montagne di parole, con le loro grafie sghembe, i loro dattiloscritti, telegrammi, articoli, faldoni – possiamo seguirne i passi attraverso il secolo breve, che non lo è stato affatto per chi come lui lo ha vissuto in ogni suo palpito. L’educazione fascista, l’amore con Michela, l’Etiopia, il fronte greco-albanese; la consapevolezza, l’adesione al comunismo, la Resistenza; la militanza politica che assorbe ogni altra vocazione, anche quella di padre, di scrittore; il terrorismo, poi il destino del partito, le verità, la perdita di identità; la vecchiaia come un «brodo sugli occhi» attraverso cui cercare di credere ancora. Questa la sorte di Pietro Migliorisi, protagonista di Storia aperta ed eteronimo di tanti uomini e donne della sua generazione: Davide Orecchio li riporta in vita attraverso una vertiginosa tessitura delle proprie parole e di quelle (in larghissima parte inedite) lasciate dal padre Alfredo Orecchio, insieme ai testi di molti comprimari, di cui nella Notafinale è offerto un toccante catalogo. In queste pagine avviene una moderna nékyia, la rievocazione di coloro che vissero in un tempo altro, nel quale splendeva il sole dell’avvenire, e si compie l’impresa di un romanzo in cui la polvere di tante voci ne compone una sola. Davide Orecchio insegue il mistero di un padre sconosciuto, ne indaga le traiettorie possibili, si impone un ferreo rigore documentario ma al tempo stesso permette alla fantasia di colmare lacune, sognare destini. Nel silenzio del passato, nel buio dell’inchiostro, cerca la luce.”

I dodici candidati
Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskij (Rizzoli)
“ “Perdonami, sono tanto stanca. Non mi cercare.” Solo questo lascia scritto Giulia, prima di scomparire nel nulla. E suo marito Giovanni, nella casa improvvisamente vuota, si sente un naufrago. Il loro è un amore fatto di cose minime: la colazione al mattino, con le fette imburrate e la marmellata; un bacio volante prima di andare al lavoro e un altro più lungo la sera, quando lui torna dalla tipografia con le dita sporche d’inchiostro; abbracciarsi in giardino, tra le rose che lei ha potato con cura. Dopo una vita insieme, non hanno ancora perso la voglia di farsi felici l’un l’altra. O almeno, così credeva lui. Adesso Giovanni, in cerca di risposte, guarda tra i libri di Giulia e dagli scaffali pesca il più voluminoso: Anna Karenina. Comincia a leggere. E si convince che sua moglie abbia trovato un altro uomo, un amante focoso, un maledetto Vronskij. Geloso e amareggiato, si chiude in tipografia, deciso a creare una copia unica del capolavoro di Tolstoj: carta pregiata, copertina in pelle, nella speranza, un giorno, di farne il suo ultimo pegno d’amore per Giulia. Ma la vita non è un romanzo, procede per strappi lievi e imprevedibili. Quando il mistero della scomparsa si svela, Giovanni capisce che c’è sempre qualcosa che ci sfugge, e tutto ciò che possiamo fare è smettere di averne paura.”
Veronica Raimo, Niente di vero (Einaudi)
“Prendete lo spirito dissacrante che trasforma nevrosi, sesso e disastri famigliari in commedia, da Fleabag al Lamento di Portnoy, aggiungete l’uso spietato che Annie Ernaux fa dei ricordi: avrete la voce di una scrittrice che in Italia ancora non c’era. Veronica Raimo sabota dall’interno il romanzo di formazione. Il suo racconto procede in modo libero, seminando sassolini indimenticabili sulla strada. All’origine ci sono una madre onnipresente che riconosce come unico principio morale la propria ansia; un padre pieno di ossessioni igieniche e architettoniche che condanna i figli a fare presto i conti con la noia; un fratello genio precoce, centro di tutte le attenzioni. Circondata da questa congrega di famigliari difettosi, Veronica scopre l’impostura per inventare se stessa. Se la memoria è una sabotatrice sopraffina e la scrittura, come il ricordo, rischia di falsare allegramente la tua identità, allora il comico è una precisa scelta letteraria, il grimaldello per aprire all’indicibile. In questa storia all’apparenza intima, c’è il racconto precisissimo di certi cortocircuiti emotivi, di quell’energia paralizzante che può essere la famiglia, dell’impresa sempre incerta che è il diventare donna. Con una prosa nervosa, pungente, dall’intelligenza sempre inquieta, Veronica Raimo ci regala un monologo ustionante.”
Daniela Ranieri, Stradario aggiornato di tutti i miei baci (Ponte alle Grazie)
“Una donna in dialogo perpetuo con sé stessa e con il mondo disegna una mappa delle sue ossessioni, del suo rapporto con l’amore e con il corpo, serbatoio di ipocondrie e nevrosi: il nuovo romanzo di Daniela Ranieri è un diario lucido e iperrealistico, in cui ogni dettaglio, ogni sussulto di vita interiore è trattato allo stesso tempo come dato scientifico e ferita dell’anima. Dalla pandemia di Covid-19 alla vita quotidiana di Roma, tutto viene fatto oggetto di narrazione ironica e burrascosa, ma in special modo le relazioni d’amore: le tante sfaccettature di Eros – l’incontro, il flirt, il piacere, le convivenze sbagliate, la violenza, l’idealizzazione, la dipendenza, l’amore puro – vengono sviscerate nello stile impareggiabile dell’autrice, un misto di strazio, risentimento, ironia impastati con la grande letteratura europea (e non solo). E forse è proprio la lingua di Daniela Ranieri il vero protagonista di questo Stradario aggiornato di tutti i miei baci, una lingua ricchissima di echi gaddiani, di irritazioni à la Thomas Bernhard, di citazioni, e allo stesso tempo inquietantemente diretta e inaudita, una lingua la cui capacità di nominare e avvicinare le cose è pari soltanto alla sua potenza nel distruggerle. Lo Stradario di Daniela Ranieri non è solo un romanzo: ha la sostanza di un corpo vivente che abita nel mondo, di una voce che avvince e persuade con la forza della grande letteratura.”