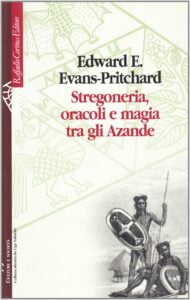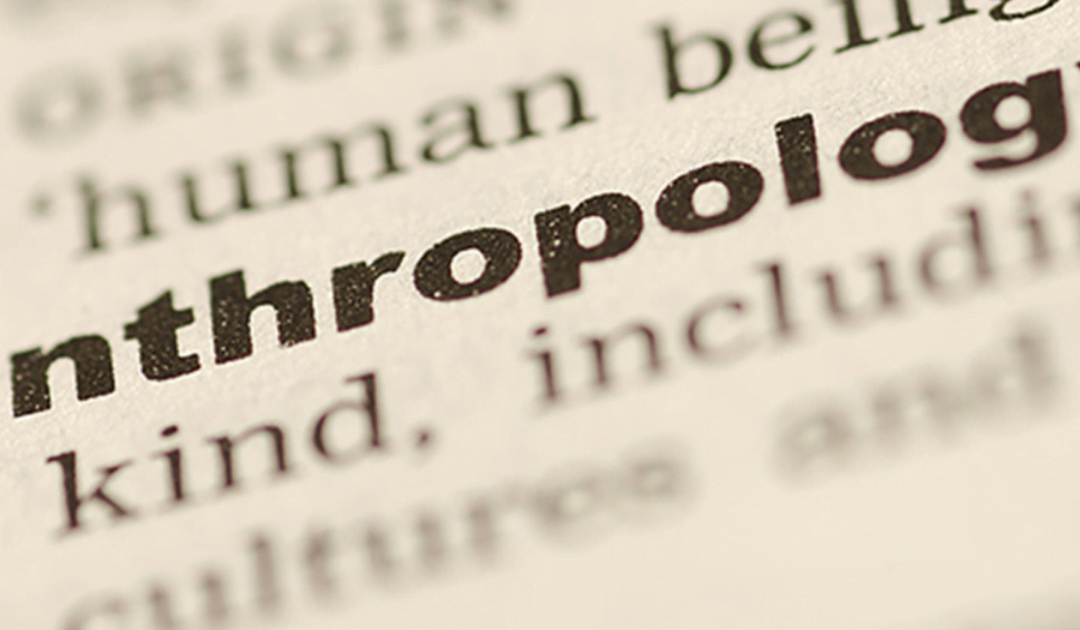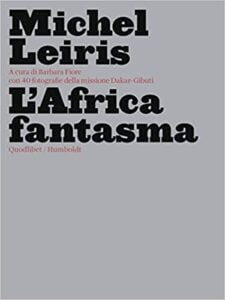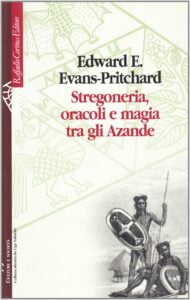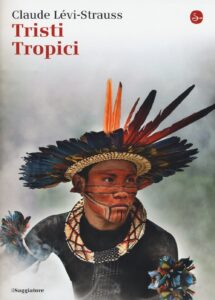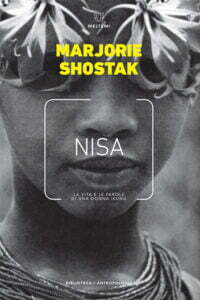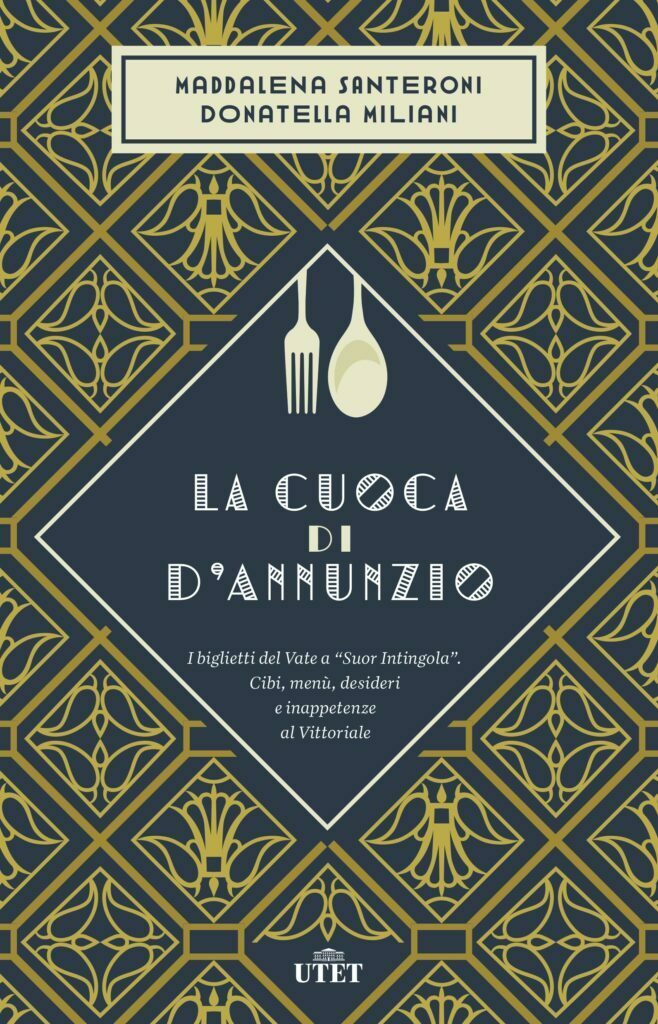Disciplina fondamentale, ma insegnata ormai solamente nei licei delle scienze umane, l’antropologia ha molto da dirci sul nostro passato, ma altrettanto sul nostro presente. Nasce nell’evoluzionismo darwiniano, cresce come strumento nelle mani del fascismo, si risveglia negli anni Cinquanta come disciplina imprescindibile per comprendere il mondo e, per dirla come la direbbe un antropologo, “il nativo che sta cambiando”.
Perché il termine stesso, “nativo”, negli anni ha assunto i significati più diversi. Da qualcosa di naturalistico in confronto all’artificiosità dell’età vittoriana a testimone di una cultura che si stava perdendo per sempre, passando per le sfumature negative a esso attribuite dall’età coloniale. In un mondo sempre più in evoluzione, e a volte anche in regressione, lo “studio dell’uomo” diviene fondamentale per capire cosa siamo stati, ma soprattutto cosa abbiamo pensato. E come il nostro modo di vedere la realtà ha influenzato ciò che invece siamo ora.
Perché studiare, quindi, l’antropologia? Ecco 10 libri, 10 classici della disciplina per capirla e apprezzarla, oggi più che mai.
…..
L’adolescenza in Samoa, Margaret Mead, 1928
Margaret Mead è un’antropologa americana attiva nella prima metà del Novecento e a lei si deve una prima piccola rivoluzione: è la prima degli americani a svolgere ricerche al di fuori della propria patria. L’obiettivo di Mead è fare ricerca su questo momento della vita da sempre considerato molto delicato, l’adolescenza, e decide di andare a studiarlo in un contesto completamente diverso da quello della sua vita di tutti i giorni. Samoa è una minuscola isola dell’Oceano Pacifico ubicata tra la Nuova Zelanda e la Polinesia Francese e le conclusioni tratte da Mead durante il suo soggiorno saranno fondamentali per i successivi studi sull’adolescenza, ma anche sul genere. L’adolescenza a Samoa è meno traumatica che in Occidente perché in questa società semplice e omogenea mancano messaggi concorrenziali e produttivistici: l’America della Mead è impestata di proibizionismo, che spinge i giovani a commettere crimini e a seguire gli ideali sbagliati. Un primo interessante sguardo sullo studio della giovinezza e delle differenze di genere.

L’Africa fantasma, Michel Leiris, 1934
Leiris scrive questo libro dopo la spedizione Dakar-Gibuti degli anni 1931-1933, una spedizione che coinvolge una dozzina di studiosi delle discipline più disparate che attraversa l’Africa allo scopo di raccogliere materiale etnografico per riempire le teche dei neonati musei europei. Una sorta di diario in cui Leiris racconta i metodi usati dai suoi colleghi per ottenere informazioni e materiali, spesso non ortodossi. Oltre a una riflessione metodologica lucida e obiettiva, Leiris si pone per la prima volta nella storia dell’antropologia un dilemma fondamentale: il posizionamento dell’antropologo nei confronti del suo interlocutore. Per la prima volta, un ricercatore si rende conto dell’impossibilità per l’intervistatore di essere neutrale nei confronti dell’intervistato in quanto anche lui è portatore di una cultura e di aspettative.
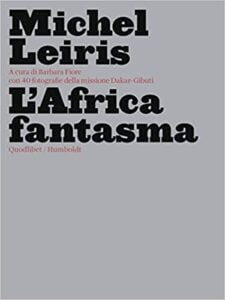
Stregoneria, oracoli e magia tra gli Azande, Edward Evan Evans-Pritchard, 1937
Prima opera importante per questo autore che focalizzerà la sua ricerca sulle società nilotiche. Gli Azande sono una popolazione stanziata fra gli attuali Sudan e Congo ed Evans-Pritchard intraprende questo percorso per studiarne inizialmente la stregoneria, ma si ritrovò a studiare la natura stessa del pensiero zande. Per gli zande, la stregoneria è un processo psichico a cui viene attribuita la disgrazia, ma si tratta di un discorso logico: la magia provoca la morte, gli stregoni lo certificano e lo confermano e a loro volta puniscono la morte con la magia. Il pensiero zande possiede quindi un carattere coerente. Il testo di Evans-Pritchard è fondamentale perché con esso si inaugura la corrente di studi sui sistemi di pensiero e pone fine alle teorie sulla mentalità pre-razionale e pre-logica. Per la prima volta, si attribuisce al pensiero di un popolo ancora erroneamente considerato “primitivo” una logicità intrinseca.