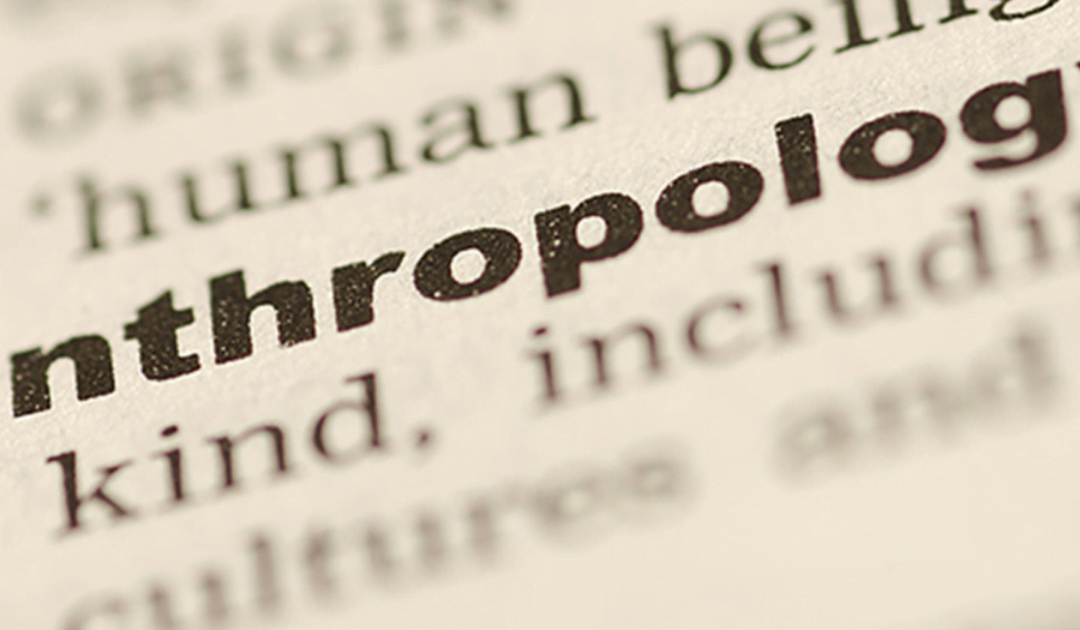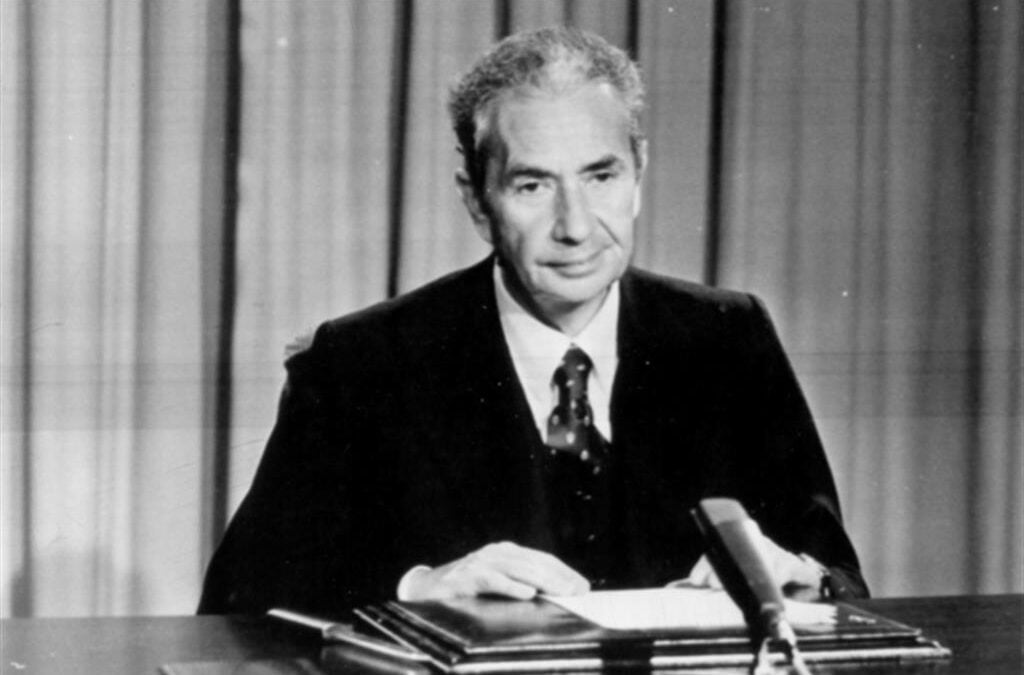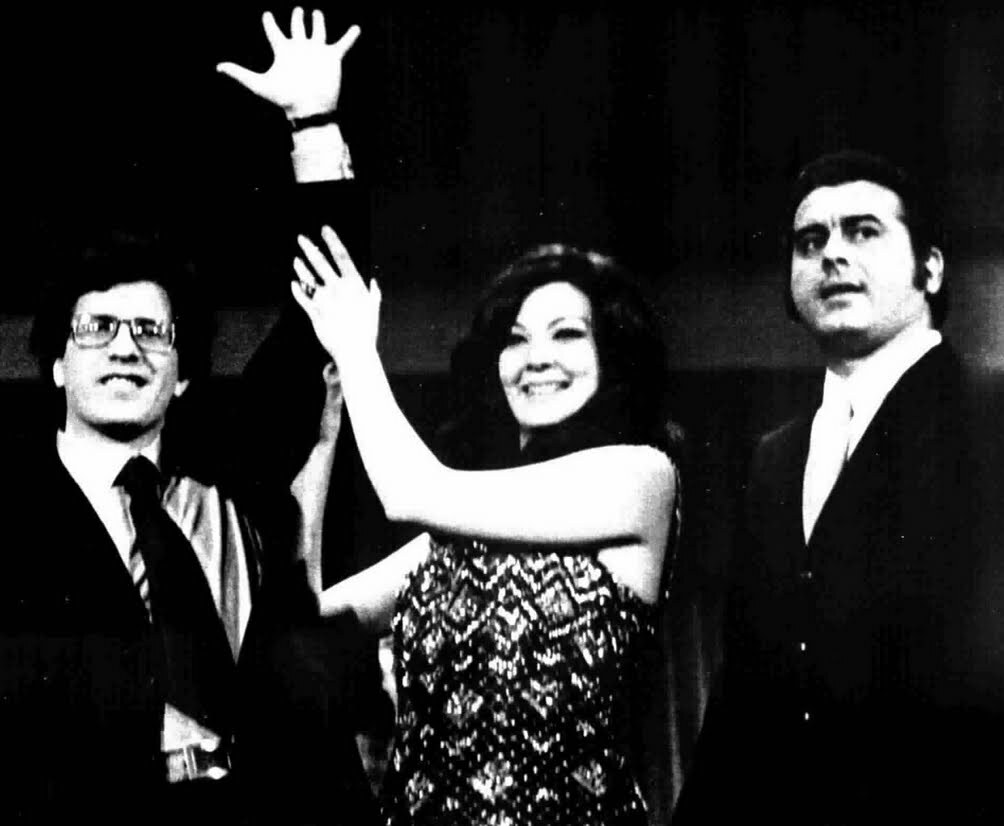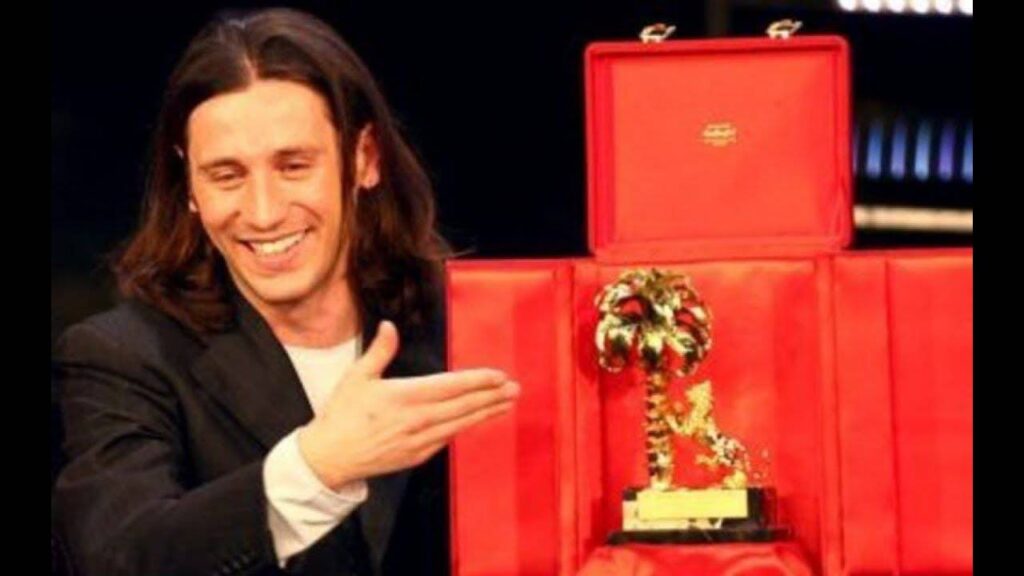Boom per il turismo “culturale”, fatturati alle stelle
Boom per il turismo “culturale”, fatturati alle stelle
All’interno di uno scenario globale estremamente positivo (+58% sul 2021), il Vecchio Continente si prende la scena, generando la metà delle entrate totali grazie alla presenza sul territorio di musei, borghi e attrazioni dal fascino intramontabile. I Paesi di punta? Germania e Italia…
Superare la tempesta, mantenendo lo sguardo fisso sull’orizzonte per scorgere nuovi e fruttuosi scenari: ecco ciò che ha fatto il settore del turismo nel corso degli ultimi anni e, stando a una serie di ricerche effettuate sulle principali testate del settore da Espresso Communication per la Fondazione Città Identitarie, uno dei principali traini su cui ha fatto e fa tutt’ora affidamento l’industria turistica globale è la cultura. Le prime conferme in merito giungono dal portale GlobeNewswire, secondo cui l’asset del cultural tourism raggiungerà quota 12 miliardi di dollari di fatturato entro il 2028 dopo aver sfiorato i 5 miliardi nel 2021. Ulteriori informazioni in merito giungono da un approfondimento stilato da Future Market Insights: stando a quanto indicato dal portale, il Nord America, l’Asia orientale e l’Africa sono alcuni dei paesi che favoriscono l’ascesa del mercato sopradescritto, ma l’Europa è la vera e propria capitale del turismo culturale. Technavio si dimostra sulla stessa lunghezza d’onda e afferma che il Vecchio Continente detiene la quota di maggioranza dell’asset perché contribuirà all’ottenimento del 50% delle entrate totali entro i prossimi 5 anni. Questo “traguardo” è dettato dal fatto che il territorio europeo può vantare la presenza di innumerevoli città, musei, borghi e attrazioni dal fascino intramontabile. Tra i principali paesi del territorio europeo, la crescita maggiore si verificherà in Germania e in Italia. A proposito di Bel Paese, le città d’arte sono diventate popolari trend virali sui social: basti pensare che su Instagram la top 3 delle città culturali più gettonate è costituita da Milano (1° con l’hashtag #milano che conta circa 39 milioni di contenuti), seguita da Roma (2° con 36 milioni di contenuti) e Napoli (3° con 21 milioni di post pubblicati), fuori dal podio Firenze con 12 milioni di contenuti e Venezia con quasi 11 milioni. Tik Tok, invece, ribalta la situazione: Napoli 1° con 17 miliardi views, seguita da Roma (2° con 11 miliardi) e Milano (3° con 7,5 miliardi). Non cambia, invece, la situazione di Firenze, che conta 1 miliardo di views, e Venezia, la quale ne vanta circa 980 milioni.
Al di là delle singole metropoli culturali, lo Stato italiano punta alla valorizzazione del propio patrimonio di riferimento attraverso iniziative mirate ed efficaci come i premi, i dibattiti e le attività didattiche organizzate dalla Fondazione Città Identitarie, realtà istituita dal movimento CulturaIdentità per promuovere l’unicità e la storia di tutto ciò che simboleggia il made in Italy. “Non è un caso che il nostro Paese sia una delle eccellenze in termini di turismo culturale – afferma Edoardo Sylos Labini, presidente della Fondazione Città Identitarie e ideatore del movimento CulturaIdentità – L’Italia è un vero e proprio polo di ricchezza sia in termini naturali sia artistici che, però, vanno promossi al meglio: per farlo è fondamentale ripartire dai borghi. In quanto fondazione e realtà fortemente radicata sul territorio, grazie all’adesione di quasi 8mila comuni dello Stivale, promuoviamo la storia, l’arte e la cultura del made in Italy. Con l’utilizzo di un linguaggio contemporaneo, applicato ad un circuito di eventi e festival, raccontiamo l’Italia più piccola, quella più bella, che ad oggi rappresenta circa il 70% dell’intero Stato italiano”.
E la Germania? L’altro Paese del Vecchio Continente che emerge per cultural attraction viene ripreso anche dal sito dell’UNESCO. A questo proposito, i musei della cittadina di Bamberga, per esempio, organizzano corsi di cucina ed eventi gastronomici all’interno delle storiche strutture per avvicinare ulteriormente locali e turisti alla propria storia e bellezza culturale. Per concludere, Outlook Traveller ha realizzato un approfondimento contenente alcune delle migliori attrazioni del territorio tedesco, tra cui la città di Brema, la quale è arricchita dalla presenza di innumerevoli edifici dai tratti rinascimentali, Amburgo, influenzata dalla corrente Art Nuoveau, le opere del Tebel Art Park di Berlino e, infine, il Music Festival di Dresda che prevede una serie di appuntamenti orchestrali con balletti e anche qualche esibizione jazz.